 E’
da poco uscito lo studio di Cline su quel periodo storico che segnò la
fine della civilizzazione dall’Età del Bronzo e l’inizio di quella
dell’Età del Ferro, nelle zone prospicienti il Mediterraneo orientale.
E’
da poco uscito lo studio di Cline su quel periodo storico che segnò la
fine della civilizzazione dall’Età del Bronzo e l’inizio di quella
dell’Età del Ferro, nelle zone prospicienti il Mediterraneo orientale.
Lo studio che raccoglie tutte le ricerche archeologiche e le teorie
storiche più recenti, sull’antichità mediterranea, giunge alla fine a
concludere che, dal momento che nessuna delle cause addotte sino ad oggi
in ipotesi, da sola, riesce a spiegare un crollo così intenso, esteso e
più o meno, sincronico, allora deve essersi trattato di un crollo
sistemico.
Crollo sistemico, teoria delle catastrofi e teoria della
complessità, sono le risorse epistemiche a cui Cline e non solo, si
rivolge per spiegare quel che fino ad oggi spiegar non si è potuto.
Sintomatico che il ricorso ad una visione sistemica o meglio di “crisi
sistemica”, si presenti in quell’oggi in cui ci rendiamo conto di essere
immersi in strutture, sistemi, complessità che stanno maturando una
profonda crisi generalizzata del nostro mondo.
E sintomatico è anche che
l’interesse per le dinamiche di passaggio da una età all’altra, si
riproponga oggi in cui, probabilmente, ci ritroviamo in una di queste
transizioni.
Insomma, l’attualità dello studio di Cline sembra basarsi
sull’analogia tra ieri ed oggi, quanto fondata o meno lo scopriremo
argomentando lo sviluppo del libro.
Siamo nel campo della storia antica (dal
-3000 a poco dopo il -1200 per l’Età del Bronzo, dal -1700 al -1200 o
poco dopo per l’attenzione specifica dello studio in oggetto) non troppo
frequentata dagli storici in quanto tali che temono di avventurarsi in
cose di cui non si ha sufficiente prova e conoscenza, così da lasciarla
prevalentemente nelle mani degli archeologi.
I fatti partono dall’esistenza di un
lungo periodo (almeno tre secoli tra circa -1500 e -1200) in cui
convissero alcune grandi civiltà tutto intorno al Mediterraneo e lungo
la piana dei due fiumi mesopotamici.
Gli Egizi, i Micenei (greci
continentali), i Minoici (cretesi), gli Ittiti (indoeuropei centro
anatolici, oggi Turchia), gli Assiri (oggi Iraq del Tigri)), i Cassiti
che furono tra i molti gestori di Babilonia, i Ciprioti, i Mitanni (con
una élite indoeuropea, oggi Iraq dell’Eufrate e Kurdistan) i Cananei
(tra Israele e Giordania).
Gli Elamiti si trovavano ad Oriente dei
Cassiti (sud Iran) e molti altri centri come Ugarit o zone come Arzawa
(Anatolia sud-occidentale a ridosso della costa, tra cui Mileto, che era
però di origine greca come altri centri della costa) e popoli come i
Kaška (Anatolia nord-orientale proprio sopra Ḫattuša capitale degli
Ittiti), completavano un quadro molto ricco e complesso.
 Quello che le ultime indagini
archeologiche hanno portato, oltre ad una migliore conoscenza di ognuna
di queste realtà tra cui la scoperta di Ugarit ma non ancora quella della
capitale dei Mitanni, Waššukanni, sono centinaia e centinaia di
tavolette iscritte.
Quello che le ultime indagini
archeologiche hanno portato, oltre ad una migliore conoscenza di ognuna
di queste realtà tra cui la scoperta di Ugarit ma non ancora quella della
capitale dei Mitanni, Waššukanni, sono centinaia e centinaia di
tavolette iscritte.
Da queste si sono apprese sostanzialmente due cose:
a) la prima è che esisteva una incredibilmente vasta ed intensa rete di
relazioni diplomatico-commerciali tra queste civiltà;
b) la seconda è che le famiglie aristocratiche che reggevano il comando delle varie civiltà, qualche volta si muovevano guerra ma più spesso si scrivevano per chiedersi informazioni, scambiarsi doni, personale tecnico e qualche volta, anche per stringere rapporti famigliari tramite scambio dei rampolli.
b) la seconda è che le famiglie aristocratiche che reggevano il comando delle varie civiltà, qualche volta si muovevano guerra ma più spesso si scrivevano per chiedersi informazioni, scambiarsi doni, personale tecnico e qualche volta, anche per stringere rapporti famigliari tramite scambio dei rampolli.
Come nota Cline, è curioso che anche quando non avevano reali rapporti di parentela, si appellassero l’un l’altro con “mio fratello, mio padre, figlio mio …”. Evidentemente si sentivano una comune famiglia (tra élite) o comunque avevano intenzione di simulare tale stato per cementare rapporti e relazioni.
Quanto alle relazioni commerciali, finalmente è stato
sdoganata la certezza che ciò che “è rimasto” (bronzo, oro, ceramica,
gioielli, coppe, spade, scudi etc.) non era che una piccola frazione di
un totale che comprendeva oli, essenze, spezie, grano, orzo, frutta e
verdura fresche o in semi, animali, schiavi esotici etc. che compaiono
negli elenchi scritti che accompagnavano gli scambi.
La nostra
periodizzazione (Età del Ferro, Bronzo, della pietra) sconta questo
riferimento a ciò che è rimasto visibile a noi ma non è affatto detto
che le civilizzazioni fossero definite da questi aspetti e non da
aspetti deperibili se non immateriali.
Quanto al bronzo, che era la
materia prima dell’epoca, necessario per far la lega era certo il rame
ma anche lo stagno e pare che quasi tutte le miniere di stagno fossero
in Afghanistan che quindi entrava a far parte di questa “circolazione
allargata”.
Quando le cose cominciarono a precipitare, si hanno urgenti e
pressanti appelli all’invio di grano per scongiurare rivolte e vere e
proprie carestie.
Questo sistema di economia
internazionalizzata, doveva aver creato quello che Ricardo chiamava il
“vantaggio comparato” ovvero una sorta di specializzazione per cui ogni
economia areale, aveva le sue specialità e mancanze.
In verità, ogni
areale o cultura di ogni ordine e tempo ha le sue naturali specialità e
mancanze ed obiettivo dello scambio commerciale è proprio quello di
coprire le une (mancanze) con lo scambio delle altre (abbondanze).
E’
che nel lungo tempo, ci si specializza sempre più sulle abbondanze
contando di poterle scambiare con le mancanze per cui, quando per
ragioni imponderabili ma che ogni tanto accadono, si interrompe il
flusso consueto degli scambi, si finisce con subire qualche mancanza
fondamentale che arriva a minare il consueto funzionamento del proprio
sistema sociale.
Si è cioè attratti per convenienza in una rete
mercantile, funzionale fino a che regge, disfunzionale quando per un
motivo o per l’altro, non regge più.
 Con
le merci, viaggiavano idee e persone e dato il vasto raggio di questo
circolo di interrelazioni, così si spiega l’ampia condivisione di
elementi estetici o culturali, storie e mitologie, tanto da far parlare
l’autore di una vera e propria “cultura e stile internazionale” del
tempo.
Con
le merci, viaggiavano idee e persone e dato il vasto raggio di questo
circolo di interrelazioni, così si spiega l’ampia condivisione di
elementi estetici o culturali, storie e mitologie, tanto da far parlare
l’autore di una vera e propria “cultura e stile internazionale” del
tempo.
Una piccola, pre-globalizzazione delle merci, delle persone,
delle idee.
Ad un certo punto, proprio a ridosso della data riportata
nel titolo (-1177), qui e lì, crollano rovinosamente i centri delle
rispettive civiltà.
Cade Micene-Titinto-Pilo-Tebe e molto altro in
Grecia, Ugarit ed il nord della Siria, Megiddo e Lachish in Israele
(dove compare la Pentapoli filistea), distruzioni anche in Mesopotamia
ed Anatolia tra cui la rovinosa caduta dell’inespugnabile Ḫattuša ma
anche lo strato VII A di Troia, quello candidato a corrispondere alla
famosa guerra omerica, Cipro e varie turbolenze che si registrano anche
in Egitto.
Perché?
Perché?
La
ricerca della causa ha offerto vari pretendenti nel tempo, ognuno ha
avuto il suo momento di fulgore aspirando a paradigma causativo
esplicativo, poi è declinato non confermato, falsificato o rimpiazzato
da uno nuovo più promettente.
Nessuno in verità è stato completamente
falsificato, nel senso che pare aver effettivamente agito ma mai con la
totalità o intensità o concentrazione temporale e sincronia di
manifestazione in un areale così vasto, tanto da poter reggere sulle sue
spalle, l’intero edificio esplicativo.
C’è dunque stato un earthquake
storm (una tempesta di terremoti) e una lungo periodo di siccità e
conseguente carestia che ha accompagnato un mutamento climatico sebbene
non particolarmente eccezionale e non repentino.
Alcuni cadute hanno
avuto probabilmente cause interne (rivolte popolari o élite
sfidanti mosse dalla crisi di gestione dell’élite in charge),
altre, cause esterne visto che si sono trovate punte di frecce e varie
armi sparse tra le rovine incendiate.
 Il crollo della rete commerciale
internazionale fu conseguenza del crollo di qualche punto importante
della rete, popoli migranti dalle proprie disgrazie e rovine confusero
territori e rotte, la legalità e sicurezza dei viaggi si fece senz’altro
problematica con la comparsa di pirati e bande organizzate.
Il crollo della rete commerciale
internazionale fu conseguenza del crollo di qualche punto importante
della rete, popoli migranti dalle proprie disgrazie e rovine confusero
territori e rotte, la legalità e sicurezza dei viaggi si fece senz’altro
problematica con la comparsa di pirati e bande organizzate.
Alcuni
hanno posto il crollo dell’economia centralizzata e palaziale e la
sostituzione con una economia capitalistica privata, tra queste ragioni
ma è probabile che tale economia convivesse con quella centralizzata già
da tempo.
Il nostro M. Liverani, uno dei pochi coraggiosi storici
dell’Antichità per altro di statura internazionale, ha segnalato che la
grande rigidità della centralizzazione palaziale fu una forma di forza
quanto ad ordine in tempi normali ma in tempi speciali divenne una
debolezza poiché caduto il palazzo e la sua élite, gli stati non avevano
più ordine e sostanza e si disgregavano facilmente.
La disgrazia
altrui provocò l’appetito del competitor per cui forse Ḫattuša, crollò
per cause proprie e solo dopo gli storici rivali degli Ittiti, i Kaška,
ne approfittarono invadendola.
La spiegazione che è andata per la
maggiore in tempi recenti, è stata quella dei famosi Popoli del Mare.
Costoro ci sono noti per via dei report storici compilati dagli egizi,
una sequenza di misteriosi nomi stranieri che non si ha idea di dove
venissero, come vivessero e dove andassero.
Qualcuno ha ipotizzato che i Shardana provenissero dalla Sardegna e i Shekelesh dalla Sicilia, i Teresh forse erano proto-etruschi.
Qualcuno ha ipotizzato che i Shardana provenissero dalla Sardegna e i Shekelesh dalla Sicilia, i Teresh forse erano proto-etruschi.
Sull’ipotesi sarda c’è da registrare i
recenti ritrovamenti dei giganti di pietra di una civiltà nuragica,
evidentemente ben più importante del sino ad oggi ritenuto. Forse non
erano neanche tutti di provenienza marina, di certo alcuni erano
guerrieri puri mentre altri erano solo nomadi, viaggiando con animali,
mogli e figli al seguito, nomadi storici o nomadi improvvisati (nel
senso di in fuga da qualche disastro), alcuni erano pacifici e si
collocarono accanto a culture stanziali locali, altri
“irresistibilmente” bellicosi.
 Era appunto il -1177, quando secondo le
fonti egizie, si ammassarono sulla costa siriana, prima di
scendere in Libano, Israele ed il delta del Nilo.
Era appunto il -1177, quando secondo le
fonti egizie, si ammassarono sulla costa siriana, prima di
scendere in Libano, Israele ed il delta del Nilo.
Alcuni, avendo carri e
bighe, cioè cavalli, hanno fatto pensare ad indoeuropei della steppa ed
oltre Danubio, così anche per una certa vis bellica distruttiva che
forse fu una delle cause di qualcuno dei crolli segnalati.
L’ipotesi Popoli del Mare, secondo Cline,
oggi è indebolita.
Per altro, escluse le cronache egizie e qualche
resto materiale che attesterebbe della presenza dei Peleset/Filistei
sulla costa israeliana (uno dei centri era Gaza) nulla più è emerso in
anni ed anni di ricerche.
Oggi si propende per una ipotesi alone.
Questa
più che una causa fu un effetto del caos in cui piombò l’intero sistema
centrato sul Mediterraneo orientale. Migrarono popoli più organizzati
ma anche meno, piccoli gruppi ma anche gruppi consistenti, armati o
pacifici, in blocco o a rate.
Ognuno dei loro spostamenti diede vita ad
altri spostamenti in un gigantesca carambola di biliardo delle
migrazioni, migranti si stanzializzarono, altri continuarono ma
raccogliendo ex-stanziali in cerca di nuove terre.
 Insomma:
Insomma:a) abbiamo molte fiorenti civiltà, autonome ma interconnesse:
b) ad un certo punto crollano più o meno tutte; c) ogni crollo è soggetto ad una pluralità di possibili cause esplicative.
Terremoti, carestie, rivolte
interne ed aggressioni esterne,
Popoli del Mare intesi come torma
indistinta di popoli in fuga, interruzione permanente della rete degli
scambi commerciali, delle vie di scambio, comunicazione e della
tessitura diplomatica, caduta delle élite storiche compongono questa
pluralità esplicativa.
Ne consegue la possibile diagnosi di crollo
sistemico, causa complessa, dinamica di catastrofi interrelate e
reciprocamente causanti.
Quello che crollò fu un sistema ed un sistema
quando crolla, crolla tutto assieme anche se non tutto nello stesso
momento, per molteplici cause in cui è impossibile discernere l’interno
dall’esterno, per dinamiche non lineari, retroazioni, perturbazioni che
vincono la resilienza dopo aver spezzato la resistenza strutturale del
sistema.
Il crollo di civiltà è un soggetto ideale
della cultura complessa, poiché ogni civiltà prima o poi crolla ed ogni
civiltà è un sistema complesso.
Un po’ come nelle scienze cognitive, si
capisce come funziona il cervello quando questo è danneggiato così si
capisce come doveva funzionare un sistema-civiltà da come e perché
questo è crollato.
Se ne è dedotto che i sistemi collassino quando sono
troppo complessi, a quel punto scendono di complessità, in genere si
scompongono in sottosistemi più semplici ed iniziano un nuovo percorso
non proprio daccapo ma retrocedendo di qualche ordine di complessità per
poi ripartire a crearne di nuova, superare il vecchio limite per poi
incorrere in uno successivo dove la dinamica si ripete secondo la logica
“un passo indietro, due in avanti”.
La complessità tende ad aumentare
per spinta naturale, i sistemi vi si ambientano sperimentando ora questa
ora quella forma di struttura secondo lo schema tentativo – fallimento –
nuovo tentativo.
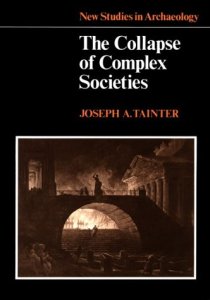 Iniziò
E. Gibbon (1776-1788 sei volumi sulla caduta dell’Impero Romano); poi
il celebre J. Tainter (1988) sul collasso delle società complesse in
generale, la cui ragione è proposta in una sorta di legge dei rendimenti
decrescenti per cui più diventa grossa una società, più diventa
complessa e costosa ed il maggior costo spinge a diventare più grossa
fino a scoppiare/crollare; poi la meno nota ed utile antologia di N.
Yoffe e G. L. Cowgill (1988) che non avanza alcuna legge specifica;
infine il celebre Collasso di J. Diamond (2005) che si basa sulla cecità
ai disequilibri demografico-ambientali. Sta di fatto che tutti si sono
occupati di singole civiltà non di sistemi di civilizzazione, quale è il
caso in questione.
Iniziò
E. Gibbon (1776-1788 sei volumi sulla caduta dell’Impero Romano); poi
il celebre J. Tainter (1988) sul collasso delle società complesse in
generale, la cui ragione è proposta in una sorta di legge dei rendimenti
decrescenti per cui più diventa grossa una società, più diventa
complessa e costosa ed il maggior costo spinge a diventare più grossa
fino a scoppiare/crollare; poi la meno nota ed utile antologia di N.
Yoffe e G. L. Cowgill (1988) che non avanza alcuna legge specifica;
infine il celebre Collasso di J. Diamond (2005) che si basa sulla cecità
ai disequilibri demografico-ambientali. Sta di fatto che tutti si sono
occupati di singole civiltà non di sistemi di civilizzazione, quale è il
caso in questione.
Il ricorso al principio di causa
complessa ci porta a darne una più puntuale specifica, utilizzando la
comparazione con il principio di causa normalmente vigente e che per
ragioni di differenziazione introdotte dall’aggettivo “complesso”, porta
a specificarsi come principio di causa semplice.
- La causa semplice è una e singolare, quella complessa è molteplice e plurale.
- Quella semplice è lineare (causa-effetto), quella complessa è non lineare (cause-retroazioni-effetti che diventano cause di altre retroazioni etc.).
- Essendo una, quella semplice è o interna o esterna al sistema considerato (che per altro non è mai considerato come sistema), quella complessa è sempre nella relazione o meglio, nelle relazioni tra l’interno e l’esterno del sistema dove all’esterno ci sono altri sistemi oltre all’ambiente generale in cui tutti i sistemi si trovano.
- Quella semplice presuppone il tempo ristretto in cui accade il fatto catastrofico, quella complessa risale a fenomeni di media-lunga durata che si compongono nel tempo e solo alla fine si compongono con l’effetto catastrofe.
- Rispetto ai sistemi umani, quella semplice ha o una matrice materiale (geografia, ambiente, economia) o ideale (sistemi di pensiero, innovazioni sociali o produttive comunque culturali, decadenza dei principi, etc.). Quando le considera abbinate, l’una è sempre causa dell’altra. Quella complessa considera tutte le variabili sincronicamente e diacronicamente.
 Secondo me, ve ne è una sesta a proposito
del fatto che quella semplice presuppone di poter trovare una legge
regolativa valida in tutti i casi, stante simili premesse (è il caso
anche di Tainter e Diamond).
Secondo me, ve ne è una sesta a proposito
del fatto che quella semplice presuppone di poter trovare una legge
regolativa valida in tutti i casi, stante simili premesse (è il caso
anche di Tainter e Diamond).
Chi scrive invece non pensa possibile
trovare simili premesse se non in casi specifici e quindi non pensa
esista una possibile legge del collasso delle civiltà o civilizzazioni.
Questa seconda posizione è tipica del “contestualismo”.
La
cultura della complessità, in genere, prevede la estrema sensibilità
alle condizioni iniziali cioè il fatto che le storie dei sistemi, sono
per lo più eterogenee, dipendendo fortemente non solo alle condizioni
iniziali ma anche dal contesto che nei casi umani è assai variabile.
Questo pattern dell’indagine e della
spiegazione dei fenomeni, quello complesso vs quello semplificato,
sconta la contraria organizzazione dei saperi contemporanea.
Come si fa a
cercare cause complesse se le informazioni sono sparse in decine di
discipline?
Quale autore infrangerà il tabù di criticare la tesi di un
collega di un’altra disciplina?
E chi potrà vantare una formazione
adeguata a questo compito enciclopedico? Che utilità si potrà vantare a
ricostruire storie che ogni volta mostrano una diversa grammatica? Come
accettare e discutere tesi ipotetiche e parziali quando il crisma della
precisione millimetrica vincola a non parlare su ciò di cui è meglio tacere? Come trattare le deduzioni da premesse ipotetiche, come trattare le “verità provvisorie”?
Eppure, come più volte andiamo ripetendo
nei nostri studi, gli oggetti, i soggetti, i fenomeni, sono
intrinsecamente complessi e laddove come oggi capita in geopolitica,
economia, organizzazione dei saperi, si deve indagare realtà complesse,
una teoria della conoscenza complessa diventa imprescindibile.
E’ la
natura dell’oggetto da conoscere che lo impone e grave danno si fa
conformando o meno a forza l’oggetto ai nostri pre-formati e limitati
presupposti conoscitivi.
Dire che l’unica conoscenza è quella
scientifica è dire che possiamo conoscere solo qualcosa di fisica, di
chimica o di biologia e nulla più, un assurdo evidente.
Che dire delle possibili analogie tra la
crisi sistemica di tremila anni fa e quella di oggi? Terremoti non sono
prevedibili e comunque eventi ambientali fuori scala certo impattano i
sistemi tanto più questi sono complessi.
 Basti ricordare il perdurante
caos nel cieli d’Europa quando eruttò il periferico vulcano islandese
nel 2011 o lo tsunami giapponese che provocò una pericolo chissà quanto
scongiurato di contaminazione nucleare che non è rischio naturale
connesso ai terremoti marini.
Basti ricordare il perdurante
caos nel cieli d’Europa quando eruttò il periferico vulcano islandese
nel 2011 o lo tsunami giapponese che provocò una pericolo chissà quanto
scongiurato di contaminazione nucleare che non è rischio naturale
connesso ai terremoti marini.
Ogni
tanto si avanza il timore di una tempesta elettromagnetica in relazione
ai flare solari, fatto che metterebbe fuori gioco l’intera economia
basata sull’elettronica (quindi praticamente tutta), evento che forse si
presentò in passato ma di cui non ci fu nessuna consapevolezza perché
non impattò su nulla di sensibile esistente.
Su i cambianti climatici
esiste una ampia letteratura ed è un fatto che al di là del più caldo o
più freddo, la “semplice” dislocazione dei climi, introduce elementi di
profonda caosizzazione nelle economie e negli stili di vita dei gruppi
sociali che hanno l’intera cultura materiale centrata su specifiche
consuetudini climatiche.
La stessa storia dei Popoli del Mare ci dice di
un periodo in cui, pressioni ambientali possono innescare movimenti
migratori che in assenza di terre libere ed ospitali, diventano caotiche
carambole di un conflittuale biliardo impazzito.
Epidemie, pandemie,
scarsità di cibo ed acqua, guerre alimentate dal mai pago sistema di
produzione degli armamenti oltretutto al servizio di istanze
geopolitiche senza scrupoli, tempeste valutarie ed economiche,
innalzamento del livello dei mari con conseguente allagamento
permanente delle coste, inquinamento, sono tutte minacce note per il
temuto accendersi del biliardo caotico.
Noi europei poi siamo seduti su
due vulcani, quello musulmano e quello africano, oggi gli africani sono
300 milioni più degli europei ma tra soli trentacinque anni , saranno
1.200 milioni in più, altro che Mare nostrum o Triton.
Le rivolte popolari interne e la
competizione tra stati sono sempre pronte ad accendersi.
Quelle tra
stati in competizione: diretta per le risorse, (si pensi alla corsa
all’Africa tra cinesi, indiani, americani ed europei o all’intricata
geoeconomia delle energie, le terre rare, il grano, la pesca, l’acqua) o
competizione indiretta per riformulare la geometria degli equilibri
geopolitici che è conditio sine qua non per affrontare i
problemi delle risorse.
Anche la competizione per il controllo più
generale delle valute di sistema, dei mercati, dei debiti e dei crediti,
sono già accese.
Tra ebola e land grabbing, petrolio-gas e bacini
idrici, primavere arabe e Stato islamico, Siria ed Ucraina, dollaro e
yuan, centro euroasiatico e nuovi trattati promossi dagli americani,
sembra noi già si sia in pieno, in uno di questi turbolenti periodi di
riconfigurazione degli assetti.
 Quanto
allo specifico crollo della rete globale, che sia Internet, il sistema
commerciale o quello banco-finanziario-valutario, c’è già chi sta
pensando di ridurne la complessità, creando almeno due sistemi separati,
quello USA – centrico e quello Cina -centrico.
Quanto
allo specifico crollo della rete globale, che sia Internet, il sistema
commerciale o quello banco-finanziario-valutario, c’è già chi sta
pensando di ridurne la complessità, creando almeno due sistemi separati,
quello USA – centrico e quello Cina -centrico.
Ma quello USA centrico o
più in generale occidentale, ha una fragilità costituzionale che ha giù
creato più di una crisi e molte altre è destinata a crearne.
Si tratta
dell’enorme ed innaturale sproporzione tra ricchezza effettiva e
ricchezza circolante, un debito di aspettative incolmabile anche in
tempi di rosee previsioni di crescita, tempi che sono stati e mai più
torneranno.
E’ dal 2009 che sento qualcuno di importante (tra i meno
stupidi) che sentenzia che “questa è una crisi sistemica” ma
alla diagnosi non è seguita una, che sia una, iniziativa correttiva.
Siamo semplicemente obesi di aria compressa ma non possiamo che fare
piccoli peti qui e lì perché i nostri stili di vita dipendono da quel
gonfiore di promesse non mantenibili che ci fa galleggiare.
 L’accentramento
palaziale, per quanto riguarda l’analogia con la diagnosi di Liverani,
non è mai stato così pronunciato come oggi lo è rispetto a gli ultimi
sessanta anni.
L’accentramento
palaziale, per quanto riguarda l’analogia con la diagnosi di Liverani,
non è mai stato così pronunciato come oggi lo è rispetto a gli ultimi
sessanta anni.
Dappertutto trionfa l’invocazione a gli uomini e donne
decisionisti, la riduzione di democrazia, il riferirsi ad un unico credo
(competere e crescere!), i poli economici o finanziari, trattati rigidi
(che sia per la moneta vedi euro o per il sistema degli scambi
internazionali, vedi TTIP, TTP, TISA, NATO), le sottili élite di
super-ricchi e super-potenti su un mare di agnostici a tutto che non sia
l’ultimo telefonino o la soddisfazione di un selfie che regali loro
almeno cinque secondi di notorietà anche se solo nel triste cortiletto
del proprio facebook.
L’imperativo di salvare il centro-sistemico che è nel sistema bancario, pena il caos generale ed anche al prezzo di trasferire i debiti bancari su i privati o sul pubblico che è il privato collettivo nè è un altro sintomo.
L’imperativo di salvare il centro-sistemico che è nel sistema bancario, pena il caos generale ed anche al prezzo di trasferire i debiti bancari su i privati o sul pubblico che è il privato collettivo nè è un altro sintomo.
Tutto sta andando verso la
radicalizzazione, la polarizzazione, la centralizzazione, l’aut-aut.
A dispetto del titolo del suo libro che evidenzia una singola
data come spartiacque del crollo del vecchio sistema, le ultime analisi
convengono sul fatto che, in realtà, si trattò di un passaggio che durò
più di un secolo.
E’ questo un dato importante perché noi siamo
abituati a segnare il tempo storico con date che fungono da spartiacque
ma nel farlo, ci danno una errata visione del tempo del cambiamento.
Stante la rivoluzione francese repubblicana al 1789, la prima repubblica
durò dodici anni, poi scomparve per quarant’anni e tornò per quattro,
scomparve di nuovo per altri diciotto anni e si affermò infine
stabilmente solo quasi un secolo dopo l’inizio del Luglio dell’89.
Questa è la differenza tra fatto cataclismatico, lineare, causa effetto e fatto di transizione anche epocale, non lineare, complesso.
Sicuramente, noi siamo in una di queste transizioni. Lunghe, travagliate e dolorose.
Questa è la differenza tra fatto cataclismatico, lineare, causa effetto e fatto di transizione anche epocale, non lineare, complesso.
Sicuramente, noi siamo in una di queste transizioni. Lunghe, travagliate e dolorose.
Ma lo studio di Cline, ci dice anche che
società interrelate, magari anche solo per via della prossimità
geografica, sono sistemi anche se come accade oggi a differenza di
tremila anni fa, noi non ne abbiamo coscienza.
La differenza di cultura,
di religione, di status economico e sociale, ci fa immaginare, quanto
ad europei mediterranei, “altro” da ciò che c’è nell’altra sponda del
mare.
Un “altro” non solo concettuale ma anche spaziale, noi siamo un
altro sistema che è in un altro luogo o dimensione.
Non è così.
I mari,
sopratutto i mari interni, non sono frontiere ma spazi di comunicazione,
da sempre.
E’ l’attualità a ricordarci che il caos imperante nell’altra
sponda del nostro mare, spesso creato da noi stessi, sta arrivando qui
da noi, direttamente dentro casa nostra.
I nuovi popoli del mare vengono
da sud e con questi popoli, volenti o nolenti, dovremmo decidere per il
nostro essere un comune sistema, se avere un futuro di evoluzione o di
catastrofe.
Recensione a E. H. Cline, 1177 a.C. Il collasso della civiltà, Bollati Boringhieri, Torino, 2014.

Commenti
Posta un commento